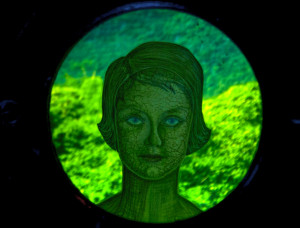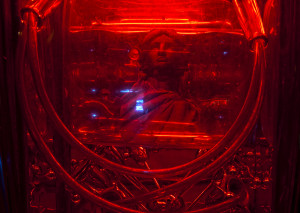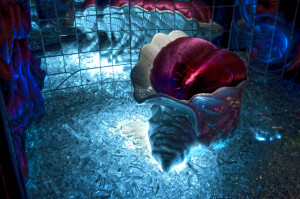Trovammo la sua casa accerchiata completamente dai rovi o quasi. Verso un imbrunire, avvolto dal Meltemi, ad Anafi, isola delle Cicladi.
L’unico ad accoglierci, stava lì da un tempo infinito. Era un albero che crollando, aveva drasticamente abbassato la cortina di spine. Mostrava anziano, l’eco della corte. Sul lato esterno della stessa, leggermente nascosto e ormai divelto, bivaccava un antico wc in muratura, all’aria aperta. Nello stesso, era evidente, un tempo confluivano anche il liquami dell’attiguo porcile sovrastante.
Tutti insieme appassionatamente.
Entrai da solo percorrendo un paio di metri tra le spine, segnandomi le gambe semi nude. La minuscola casa di campagna, con la porta di entrata orientata a sud, era in cima ad un vespro di ricordi di civiltà contadine, avvolta nel nulla di un isola battuta dal vento. Quasi intatta. Qualcuno, di cui ho cercato invano il nome tra i resti, era vissuto lì dentro. L’aveva lasciata così, o tale era rimasta, credo per quasi 80 anni.
Il nido di “un pettirosso da combattimento”. Ho pensato ai suoi ultimi attimi qui dentro. Nulla era stato asportato e il tempo l’aveva divorato con appetito. Forse c’era morto di notte. Forse lo avevano portato via a braccia ormai consunto. O forse lo avevano trovato poco lontano ubriaco e affogato nei rovi, mezzo nudo mentre le capre gli leccavano la pelle bianca e ancora immacolata.
Era la casa di uno scapolo, che dormiva su un materasso di crine, con le tavole a supporto. Abbandonato sul letto, un pesante cappotto di lana verde, con un largo bavero. Una scarpa nel forno, bottiglie negli stipetti sverginati dal tempo e dall’acqua, che abbondante da allora cade al loro interno. Il tetto parzialmente crollato.
L’elogio della povertà riporta vagamente a quella tanto amabile e ipocrita attitudine malamente osservata, che parla di prendere il buono, da ogni cosa che c’è. Il fiore all’occhiello, di chi riesce a condurre una vita il più possibile senza crepe, ritagliandosi un futuro, pur che sia pieno di popolarità. Non vogliamo più invecchiare, lo ammetto colpevole, talmente siamo mediocremente predisposti all’idea dell’eternità.
Per Isidoros, così ho voluto chiamarlo, la povertà era una pratica di vita e come l’idea della morte, era forza vitale inconsapevole a prescindere. La mia generazione, è stata il ponte che ha traghettato veloce e spedita, verso l’odierno domenicale buonismo futile e tendenzioso. Così pieno delle necessarie distrazioni, per noi così servi nel comunicare tutta la nostra paura di rimanere soli. Terrorizzati di sparire, senza lasciare tracce del nostro passaggio. Qualunque esso sia . Tanto quanto chi ci ha preceduto.
All you need is less, è il mantra divenuto indispensabile per alcuni tipi di dignità che hanno tutto a prescindere, e che riescono a fotografare anche il loro biscotti inzuppati di urla e di banalità domenicali. Io non ho più voglia di essere buono, né di diventare ricco. Posso solo tentare di essere meraviglioso. Non so davvero, se avrò ancora il tempo per farlo tutto.
Isidoros, non aveva altro che la sua povertà, e nessuno lo ha cantato. Roba da “Domenica delle salme”.
Ho pensato alle sue domeniche. Ai suoi lunedì e a tutti i suoi santi giorni tutti eguali. Alla perenne compagnia delle mosche e dei porci, in casa sua. Agli interminabili silenzi, del suo calvario quotidiano. Era alto appena 1,65 forse poco di più. Viveva per le sue le capre, che sull’isola ancora abbondano, dalla mattina alla sera. Sicuramente aveva un asino, data la lontananza della sua casa, da ogni dove.
Declinati e incartapecoriti, e ormai tutt’uno con la spalliera della sedia divelta, i suoi pantaloni. Probabilmente gli unici che aveva a proteggere il corpo. Mi sono arrogato il diritto di prenderli. Quasi un reperto garibaldino.
A Isidoros, e alla sua memoria di cafone autentico e verace, ho dedicato il mio viaggio nelle Cicladi. I suoi pantaloni parlano chiaro. Abbondanti cuciture, alcune a macchina, altre con lo spago, mi dicono che aveva le pezze al culo, perché altro non poteva permettersi, e per questo per me, è autentico più di ogni altra cosa.
Quei pantaloni sono stati un impiccio durante tutto il viaggio, tanto quanto i cantautori greci. Negli occhi di chi viaggiava con me, c’era scritto a chiare lettere… “ma perchè non li butti ? ”. Hanno passato anche il check in. Io avevo solo voglia di metterli sotto vetro, come un reperto d’annata, per celebrare il Povero Ignoto, a cui qualcuno dovrebbe fare un monumento temo, ormai considerata la sua inutilità. Un reperto buonista. Il migliore.
I pantaloni girano nella lavatrice e non vedo l’ora che siano asciutti per poterveli mostrare. Eccoli.